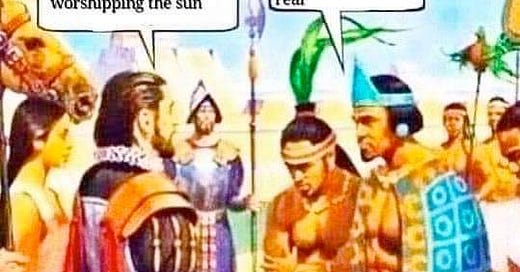Blocco #10 – Linguaggio e autorità
Parliamo per descrivere emozioni, ubbidiamo per non sentirci responsabili
Nella puntata precedente abbiamo parlato del reality check, ovvero del meccanismo usato dagli esseri umani per distinguere la realtà dalle illusioni generate dal pensiero astratto. L'antropologia suggerisce che la nostra capacità di astrazione sia nata grazie a diversi fattori, tra cui la scoperta del fuoco e il consumo di Psilocybe (teoria della scimmia drogata). Qualsiasi sia l'origine del pensiero astratto, esso ha potenziato la nostra capacità di concettualizzare idee e costruire simbolismi, che a loro volta hanno consentito lo sviluppo di numerose abilità mentali, che potremmo identificare come le prime tecnologie sociali:
Linguaggio: capacità di gestire sintassi e lessico
Identificazione di schemi: usare esperienze pregresse per colmare lacune sensoriali
Pianificazione: esprimere previsioni (o ipotesi) e pianificare strategie per affrontarle
Narrazione: condivisione di realtà fittizie con scopo sociale (di svago o metaforico)
Credenze: costruzione condivisa di un'ideologia, filosofia, teologia o metafisica
Autorità: prova di forza verbale che permette di dare ordini senza applicare forza fisica
Gerarchia: codifica di un sistema di pensiero atto a giustificare leggi e classi sociali
Questo elenco può sembrare un'accozzaglia di termini presi a caso da un libro di pedagogia, ma in realtà hanno valenza pratica. Vediamo un esempio.
All'inizio del neolitico un gruppo di cacciatori perde di vista un branco di caribou. I cacciatori hanno già vissuto esperienze simili, quindi usano tali ricordi per identificare uno schema ed intuire da che parte sono fuggiti gli animali. A questo punto possono pianificare la prossima mossa, esprimendo diverse previsioni (o ipotesi) sulla direzione nella quale si è spostato il branco. Dopo qualche discussione un individuo riesce ad imporre la sua autorità verbale, usando un'abile narrativa per convincere il gruppo ad accettare il suo piano di caccia. Se la previsione è corretta i cacciatori si sfameranno grazie al nuovo leader, che d'ora in poi verrà ascoltato con maggiore attenzione. L'episodio potrebbe consolidare la struttura gerarchia astratta del gruppo, o essere l'incipit di una credenza che attribuisce al nostro eroe poteri magici o divini, degni di essere tramandati ai posteri.
Abilità di questo tipo hanno fornito molti vantaggi evolutivi alla specie umana. Ad esempio, possiamo analizzare l'esempio della caccia dei caribou dal punto di vista del rapporto costi-benefici che abbiamo introdotto studiando l'economia primordiale. In questo contesto la capacità di pianificazione permette di cacciare in modo più efficiente. Invece di aggredire la selvaggina all'aperto (prede con basso Benefit-Cost Ratio, in breve BCR), l'uomo ha imparato a studiarne i movimenti e ordire piani per spingere le prede in anfratti stretti, dove i caribou sono meno offensivi perché incapaci di caricare gli attaccanti. Così facendo gli uomini del neolitico hanno imparato a trasformare prede con basso BCR in prede ad alto BCR.
Alcune delle abilità indotte dal pensiero astratto si sono rivelate un'arma a doppio taglio, perché hanno facilitato la diffusione di superstizioni e credenze. Il linguaggio ha infatti permesso di esprimere il disagio che proviamo quando infliggiamo sofferenza ad altri mammiferi. Questo senso di colpa, unito alla capacità di sviluppare credenze e gerarchie astratte, spiega perché molte religioni affermano che l'uomo è stato creato per dominare sul mondo animale. Prima del neolitico esistevano molte credenze spirituali (quali animismo, sciamanesimo, totemismo e il culto degli antenati), ma erano quasi tutte prive di gerarchia sociale. L'adozione di agricoltura e allevamento ha stimolato lo sviluppo delle religioni organizzate: con la giusta narrativa l'uccisione di un bue diventa un atto sacro, richiesto dal dio, anziché una vile necessità alimentare. Ciò suggerisce che la nostra naturale empatia verso i mammiferi, unita alla capacità di inventare giustificazioni astratte, potrebbe essere uno dei fattori che ci ha spinto ad abbandonare la spiritualità preistorica a favore della religione organizzata. Ciò è confermato dal fatto che durante il neolitico sono nate numerose ideologie che giustificano le gerarchie di potere astratto, quasi tutte fondate sull'uso di metodi pacifici per stabilire chi comanda. Abbiamo accettato di riconoscere il potere dei sacerdoti per sentirci meno violenti, e macellare gli animali senza sensi di colpa.
La credenza in una entità superiore, unità all'invenzione del potere astratto, ha alimentato i processi mentali che giustificano la nostra obbedienza all'autorità. Abbiamo iniziato ascoltando le storie dei primi sciamani, e coi millenni ci siamo abituati a credere alle favole di principi, re, papi, imperatori, ministri e capi di stato. Preferiamo delegare ad altri le conseguenze del nostro stile di vita, piuttosto che assumerci delle responsabilità. Ci sentiamo meno in colpa a comprare il pollo al banco alimentari piuttosto che tirare il collo ad una gallina.
Ciò vale anche all'interno dei piccoli gruppi sociali. Consideriamo un gruppo di individui che non riesce a prendere una decisione, e supponiamo che qualcuno si offra come leader. Se il leader è democratico, e consulta gli individui uno ad uno, faticherà a trovare una soluzione che soddisfi tutti. Se invece impone una soluzione approvata dalla maggioranza, chi non è d'accordo si lamenterà, ma seguirà comunque il branco, per non restare escluso. Chi si lamenta è spesso inconsapevole di essere “contento” di tale situazione, perché il subire le decisioni altrui fornisce una giustificazione al suo disagio. Inoltre, se la decisione del leader si rivelasse sbagliata o immorale, chi si è lamentato può uscirne pulito dicendo “non ero d'accordo”, o “stavo solo rispettando la legge” (Norimberga docet).
Ciò spiega perché la maggior parte degli esseri umani preferisce delegare la soluzione dei propri problemi a genitori, comunità o stato, piuttosto che lottare per un cambiamento dal basso. E' più comodo credere che disuguaglianza, disoccupazione e inquinamento siano conseguenze di decisioni prese dall'alto, piuttosto che sentirsi responsabili dei nostri comportamenti individuali. Scegliamo di rispettare il potere astratto, per quanto virtuale e immaginario, perché ci libera da colpe e responsabilità. Non siamo poi così diversi dal contadino che credeva alle favole del sacerdote per uccidere un bue senza sentirsi in colpa.
E’ interessante osservare che il linguaggio può essere pensato come l'evoluzione della naturale empatia animale. Siamo quasi tutti capaci di comunicare con gli animali, specialmente coi mammiferi, poiché condividiamo con loro il significato di gesti, versi e sguardi. Questo è uno dei motivi per cui ci sentiamo in colpa nell'uccidere un mammifero ma sterminiamo senza problemi le altre specie. Animali come pesci e insetti non posseggono i muscoli facciali necessari ad esprimere uno sguardo di dolore a noi familiare. Ciò è confermato dal fatto che una delle differenze tra cani e lupi è che i cani hanno sviluppato i muscoli necessari per mimare lo sguardo umano, per cui li “capiamo” meglio. Per lo stesso motivo ci viene naturale parlare il bambinese con neonati, cuccioli, anziani o handicappati. Abbiamo un sistema di comunicazione innato per interagire con chi è dotato di una ridotta capacità linguistica.
Questa forma di comunicazione, che potremmo chiamare linguaggio emotivo, serve a costruire relazioni sociali e affettive più della comunicazione orale e scritta. Una relazione si fonda su gesti, sguardi, esperienze, abbracci ed espressioni facciali, piuttosto che su quanto viene tradotto in simboli, parole o frasi. Il linguaggio umano non ha lo scopo di trasmettere emozioni, ma di descriverle. La nostra capacità di identificare simboli serve sia ad evocare gli aspetti semantici di un termine, sia a descrivere le regole sintattiche che costituiscono la struttura del linguaggio. In altre parole il linguaggio ha due scopi principali: descrivere le emozioni e condividere le regole del protocollo di comunicazione1.
Se il linguaggio umano è un'evoluzione della comunicazione animale, è sensato supporre che il linguaggio odierno sia una tappa intermedia, e che in futuro potrebbero esistere forme di comunicazione più evolute. Una di queste potrebbe essere il linguaggio macchina usato dai computer. Il software permette il funzionamento di tecnologie come internet, che a sua volta permette di interagire in modo più efficiente, descrivendo sia emozioni che protocolli di comunicazione. Da questo punto di vista internet potrebbe essere una forma evoluta del linguaggio scritto, e quindi un prodotto superiore del pensiero astratto.
Riassumendo, gli esseri umani dispongono di molteplici forme di comunicazione, che chiameremo impropriamente tipi di linguaggio2. Il linguaggio di basso livello (emotivo o animale) viene usato fine a se stesso, per comunicare emozioni (abbracci, sguardi, baci). Il linguaggio di alto livello (verbale o scritto) viene usato per scopi più complessi, quali la condivisione di esperienze, concetti, idee, strategie e progetti (incluse le teorie sulla realtà, come ad esempio la metafisica). Uno degli scopi del linguaggio di alto livello è di connettere cervelli diversi, cioè di confrontare le singole realtà soggettive per creare quell'intersezione di esperienze comuni che chiamiamo realtà oggettiva. Da questo punto di vista il linguaggio è lo strumento che usiamo per applicare il reality check a livello sociale. Esso consente di cooperare su larga scala, in termini di numero ed area geografica, ma anche attraverso il tempo, di generazione in generazione. Ciò conferma l'interpretazione del cyberspazio come forma superiore di linguaggio, poiché internet estende questi vantaggi su scala globale, costituendo una realtà oggettiva in grado di aggiornarsi in poche frazioni di secondo.
Conclusioni
Le diverse evoluzioni del linguaggio possono essere considerate gli strumenti che usiamo quotidianamente per trovare consenso su ciò che è oggettivo o “reale”. Più saliamo di livello, più accurata è la funzione del linguaggio come reality check. Ecco perché internet è lo strumento principe per distinguere il vero dal falso. Per lo stesso motivo l'abilità narrativa di una persona è l'arma più potente di cui disponiamo per convincere gli altri a credere nelle nostre idee. E' attraverso la narrazione che riusciamo a trasformare i concetti astratti soggettivi in concetti astratti condivisi, cioè oggettivi, e quindi “reali”. Nella prossima puntata approfondiremo il ruolo della narrazione e spiegheremo come essa sia lo strumento più adatto a trasformare la società. E' grazie all'abilità narrativa che gli individui più furbi, quali politici, dittatori o capi di stato, riescono a prendere il controllo su popoli e nazioni.
Con l'avvento del neolitico e della società agraria, gli esseri umani hanno sostituito la caccia con la narrazione, e i cacciatori-narratori sono diventati i nuovi capobranco: noi siamo le prede, i politici i cacciatori.
Secondo alcune teorie, senza il linguaggio gli esseri umani riuscirebbe a gestire al massimo comunità composte da poche centinaia di individui (vedasi il numero di Dunbar)
Esistono forme di comunicazione né verbali né scritte, come ad esempio il linguaggio del corpo. Ma siccome usiamo comunque il termine linguaggio (in questo caso: linguaggio del corpo), per praticità in questa sede continueremo ad usare la parola linguaggio in senso lato